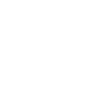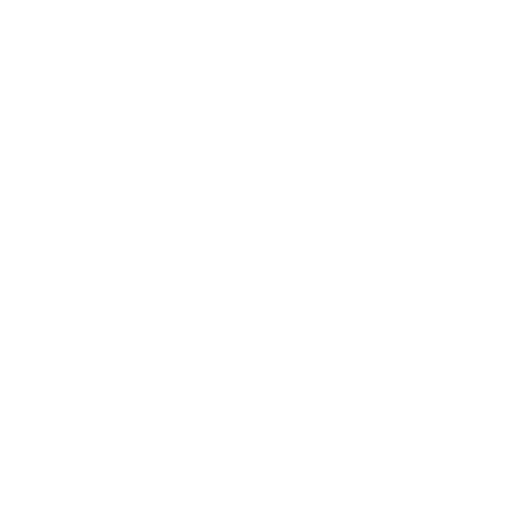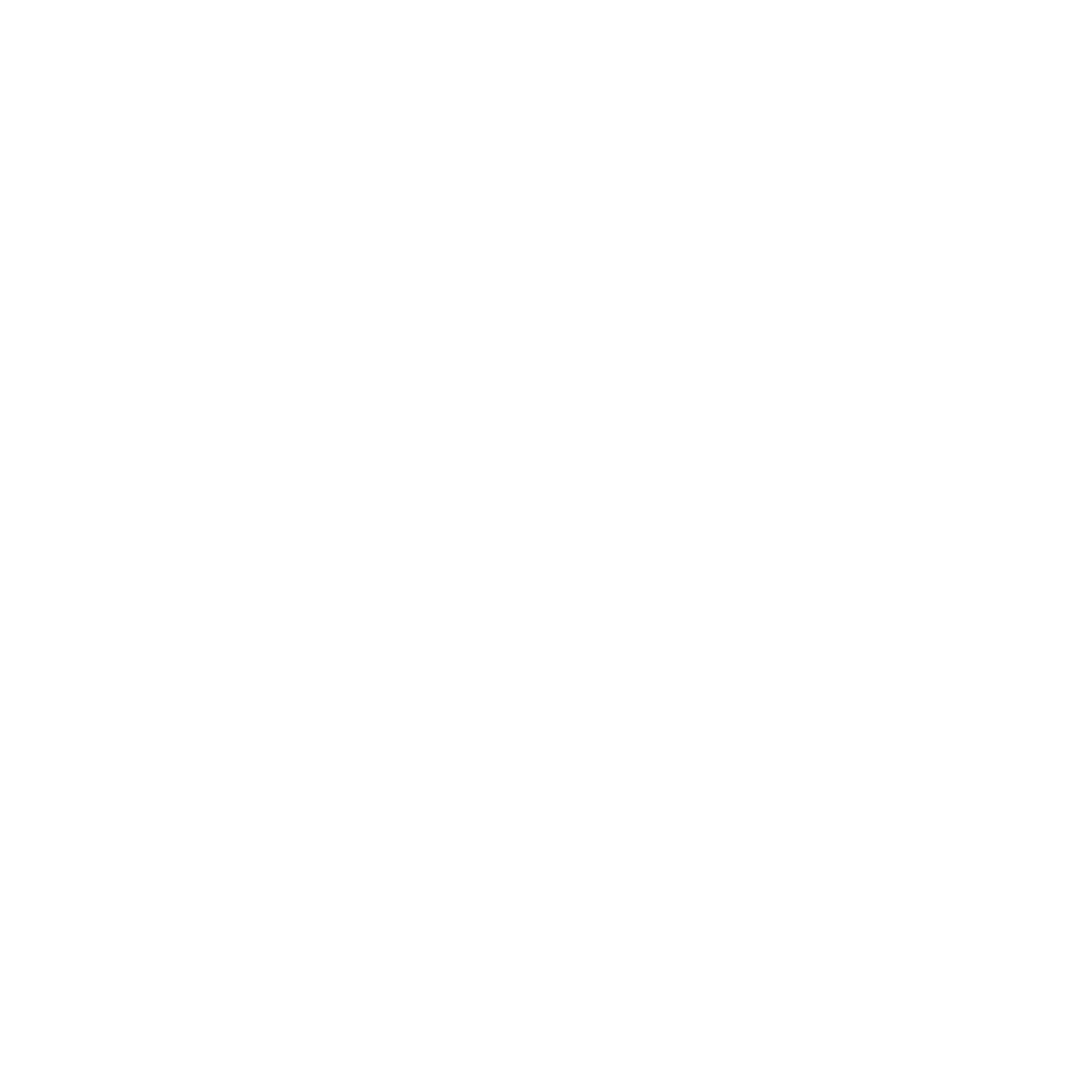Cipresso calvo
Il cipresso calvo, detto anche cipresso di palude, appartiene alla famiglia delle Taxodiacee ed è una conifera originaria delle zone paludose della Florida e del Golfo del Messico, dove il Mississippi sfocia diramandosi in innumerevoli canali.

Il cipresso calvo, detto anche cipresso di palude, appartiene alla famiglia delle Taxodiacee ed è una conifera originaria delle zone paludose della Florida e del Golfo del Messico, dove il Mississippi sfocia diramandosi in innumerevoli canali. Nelle zone a lungo inondate, dove l'acqua raggiunge livelli considerevoli, si insediano foreste miste di latifoglie sempreverdi e decidue e di aghifoglie decidue, tra le quali figurano due specie del genere Taxodium.
Si tratta di un albero maestoso, che può raggiungere un'altezza di 40 metri, con il tronco dalla corteccia bruno-rossastra, dilatato alla base, chioma strettamente piramidale e foglie che in autunno, ancora attaccate ai rametti più giovani, cambiano colore e arrossano prima di cadere, ricoprendo il terreno circostante. La principale caratteristica è data però dalle radici, che sono piantate profondamente nel fango stagnante, poco o per niente ossigenato; da esse sporgono alcune ramificazioni al di sopra del normale livello dell'acqua (anche ad una certa distanza dal tronco), per un’altezza che talvolta raggiunge i due metri: i pneumatofori, o meglio pneumatorizze. I pneumatofori hanno una struttura anatomica specializzata, con pori nella corteccia (lenticelle) che permettono all'aria di entrare e circolare all'interno della radice. Per queste sue caratteristiche il cipresso calvo è molto comune in parchi e giardini, anche storici, della pianura padana, spesso sito sul bordo di canali, stagni e laghetti, da cui lascia sporgere le singolari radici respiratorie.
Nelle formazioni forestali in cui vive spontaneo, i rami del cipresso calvo, come quelli delle altre piante, sono inghirlandati da ciuffi e festoni penduli di "muschio spagnolo" (Tillandsia usneoides L.), che costituiscono la sua unica decorazione nel periodo invernale. Nonostante il nome, non si tratta di un muschio, ma di una Bromeliacea epifita a fusticini sottili e flessibili (utilizzati secchi come sostituto del crine animale). Vari rappresentanti di questa famiglia, a cui appartengono anche l'ananas e varie specie ornamentali, si possono osservare nel periodo invernale nella serra indicata appunto come “serra delle Bromeliacee”.
Si trovano nell'Orto botanico patavino alcuni vetusti individui di cipresso calvo: uno nel settore delle piante dei Colli Euganei, presso la porta sud, e tre presso il ponte di ingresso (ponte delle priare), lungo il canale, dove sono evidenti i pneumatofori. Sempre presso il canale, un quarto individuo si differenzia leggermente dagli altri per la forma più rotondeggiante (e non ovale) delle pigne coriacee (galbuli); esso appartiene ad una specie diversa: Taxodium ascendens Brongn.
In prossimità del ponte d'ingresso, accanto ai cipressi calvi, vive una annosa pianta di criptomeria, o cipresso del Giappone (Cryptomeria japonica G. Don), una Taxodiacea che nella zona centrale delle isole nipponiche entra a far parte delle foreste di clima umido della fascia temperato fredda, prevalentemente di faggio con querce, frassini, aceri e sorbi. Questo esemplare riveste un particolare interesse storico perché costituisce il primo introdotto in Italia, nel 1850. Oggi questo albero colonnare, dalla corteccia bruno-rossastra e dalla chioma piramidale, è coltivato soprattutto nell'Italia meridionale per rimboschimento; esso è però frequente anche in molti giardini e parchi, dove è particolarmente apprezzatao per il fatto che le foglie, aghiformi e persistenti, cambiano di colore con le stagioni passando dal verde chiaro al verde glauco, fino al violetto durante l'inverno. Il suo polline risulta altamente allergenico.
Le Taxodiacee costituiscono una delle più interessanti famiglie di conifere, i cui fossili risalgono a circa 150 milioni di anni fa; attualmente è rappresentata da specie a distribuzione ampliamente dispersa, che sono i resti di popolazioni molto più diffuse nel terziario. Sono caratterizzate dalla presenza di foglie aghiformi o squamiformi, persistenti o decidue, inserite a spirale sui rami e di strobili lignificati. Le piante decidue (Taxodium e Metasequoia) hanno le foglie inserite su brevi rami laterali, brachiblasti, assieme ai quali cadono in autunno, a loro volta portati da rami normali.