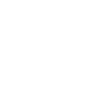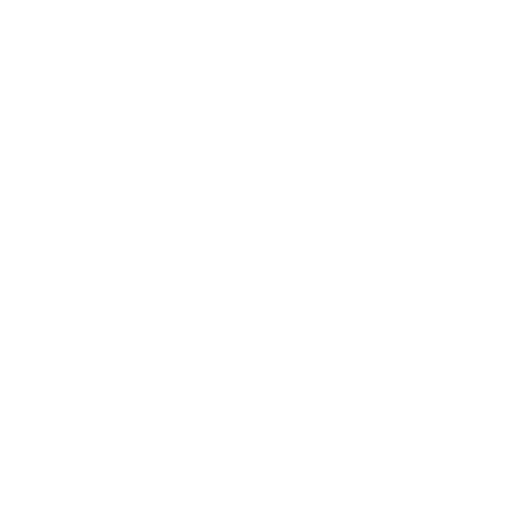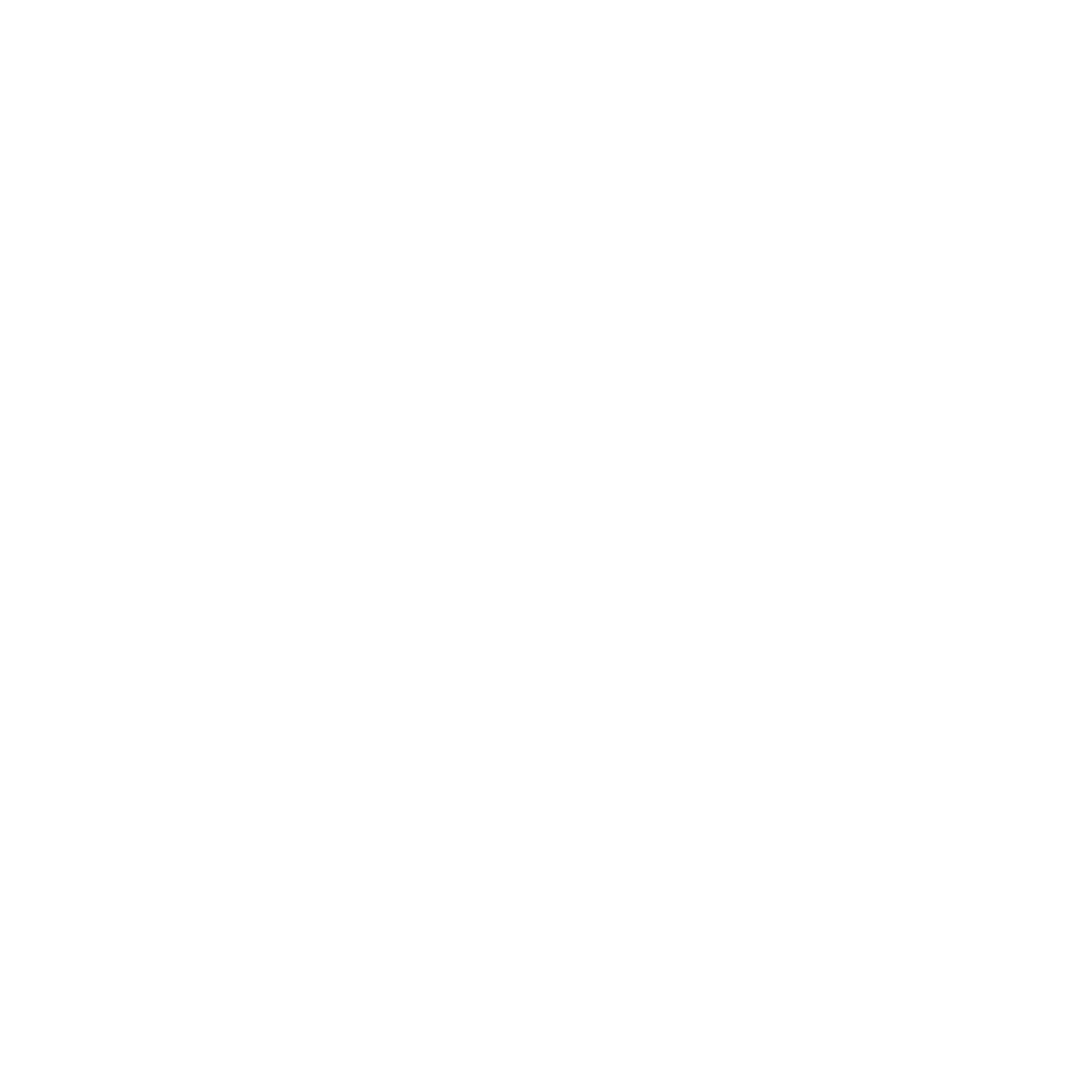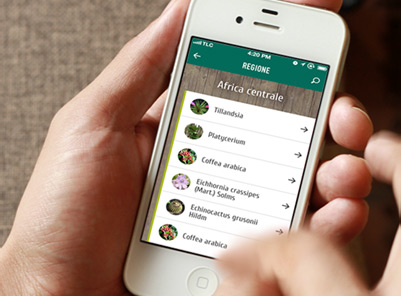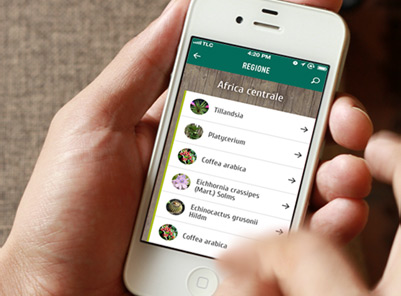Protagonista di Bestiari, Erbari, Lapidari, un documentario "enciclopedia" tra arte e Natura
Scopri di più
Dal 3 luglio al 7 settembre gli appuntamenti estivi dell'Orto, per riscoprire l'importanza e la bellezza della natura che ci circonda
Scopri il programma
A partire dal 29 giugno, uno strumento in più per visitare l'Orto botanico con i bambini
Scopri di più
È disponibile in biglietteria l'audioguida multilingua
Scopri di più
Sono visitabili l'Orto antico, le serre ottocentesche, l’arboreto e il Museo botanico
scopri di più
Visitabili negli orari di apertura, comprese nel biglietto d'ingresso
SCopri di più
Il nuovo biglietto integrato dell'Università di Padova
Scopri di piùSpecie botaniche
-
 Elettaria cardamomum
Elettaria cardamomum
Il “cardamomo verde”, o “vero cardamomo”, è specie nativa dell’India meridionale dove, per il suo aroma pungente, trova largo impiego in cucina nella preparazione di piatti dolci e salati oltre che per bevande tipiche (caffè alla turca, tè iraniano). E’ una specie perenne a rizoma legnoso da cui si dipartono lunghe foglie lanceolate e una spiga di grandi fiori violetti o, più raramente, bianchi che producono frutti a capsula contenenti parecchi semi scuri. La spezia è data da questi ultimi che vengono impiegati freschi poiché all’aria perdono rapidamente il loro aroma. A scopo terapeutico, i semi di cardamomo si sono dimostrati efficaci in caso di disturbi gastrointestinali e come antisettico. La pianta, nota anche agli antichi Greci e Romani, occupa il terzo posto tra le spezie più care al mondo.
-
 Azolla filiculoides
Azolla filiculoides
L'azolla maggiore è una specie originaria delle zone tropicali del continente americano ormai divenuta subcosmopolita e presente come avventizia in molte regioni d'Italia. Cresce sulla superficie di acque stagnanti o a scorrimento molto lento, sopportando bene anche una relativamente forte eutrofizzazione. La pianta ospita in una cavità basale della fronda un cianobatterio simbionte, Anabaena azollae in grado di fissare l'azoto atmosferico rendendolo disponibile alla pianta. Per questo motivo le specie di questo genere hanno uno sviluppo molto rapido e divengono spesso infestanti. Il nome generico deriva dal greco 'azo' (seccare) e 'ollyo' (rovinare) per il fatto che non sopravvive se tolta dall'acqua; il nome specifico, dal diminutivo latino di 'filix' (felce) e dal greco 'eidos' (apparenza), si riferisce alla somiglianza con una piccola felce. Forma biologica: idrofita natante. Periodo di sporificazione: luglio-settembre.
-
 Philodendron bipinnatifidum
Philodendron bipinnatifidum
Arbusto sempreverde appartenente alla famiglia delle Araceae, è originario del Sud America e, più specificatamente, delle foreste pluviali brasiliane ma viene ampiamente coltivato lungo le coste americane così come in alcune zone dell’Asia quali le Filippine.
Il fusto, che può superare i tre metri d’altezza, è a rapida crescita e spesso produce lunghe radici aeree vicino alla base, dalle quali è derivato uno dei nomi vernacolari di questa specie (fillodendro àncora). Le foglie sono grandi, arrivano tranquillamente al metro di lunghezza, profondamente incise e simili a quelle di Monstera deliciosa Liebm., specie della stessa famiglia e originaria nell’America centrale. L’infiorescenza, che si sviluppa tardivamente, consiste in un lungo spadice bianco-verde parzialmente avvolto da una spata verde esteriormente e color crema all’interno; sullo spadice sono presenti migliaia di piccoli fiori con i maschili concentrati all’apice, i femminili alla base e una serie di fiori maschili sterili nella parte centrale. Con l’inizio della fioritura si sviluppano, all’interno della spata, temperature piuttosto elevate che, unitamente all’odore, attirano gli impollinatori, principalmente alcuni coleotteri notturni.
La specie contiene delle sostanze tossiche, soprattutto ossalati di calcio, che la rendono dannosa sia per ingestione che per contatto.
-
 Tamarindus indica
Tamarindus indica
Il tamarindo è un albero originario dell’Africa orientale, ma è presente anche in altre zone tropicali asiatiche e, dal sedicesimo secolo, anche americane. Pianta a crescita piuttosto lenta, è però longeva e, in condizioni favorevoli, può superare i 30m d’altezza per un diametro di 7-8m. Porta foglie pennato composte e caduche solo nelle zone in cui la stagione secca è prolungata, I fiori sono riuniti in piccoli racemi, sono gialli con venature rosse o arancioni mentre i legumi, lunghi 10-15cm, sono legnosi e leggermente incurvati. Usato, soprattutto dalle popolazioni locali, per usi medicinali (es. antibatterico, antimalarico) è invece conosciuto in tutto il mondo per l’uso alimentare dei suoi frutti, la cui polpa viene usata sia per preparare piatti dolci o salati che per fare bevande rinfrescanti.
-
 Aquilegia vulgaris
Aquilegia vulgaris
L'aquilegia comune è una specie a vasta distribuzione eurasiatico-temperata presente in tutte le regioni d’Italia salvo che in Sardegna, più spesso coltivata nei giardini e inselvatichita. Cresce in faggete e boschi misti, le forme sfuggite alla coltivazione anche in ambienti urbanizzati. Tutta la pianta e soprattutto i semi sono tossici per il contenuto in glucosidi cardioattivi che liberano acido cianidrico e alcaloidi (aquilegina). Il nome generico, di antico uso, ha etimologia incerta: potrebbe derivare dal latino 'aquilegium' (recipiente per l'acqua) per la forma dei fiori, o da 'aquila' per gli speroni simili al becco dell'aquila; il nome specifico deriva dal latino ‘dumétum’ (cespuglio) e ‘colo’ (abito) e significa quindi ‘che vive fra i cespugli’. Forma biologica: emicriptofita scaposa. Periodo di fioritura: giugno-agosto. Syn.: Aquilegia vulgaris auct. Fl. Ital.
-
 Lavandula angustifolia
Lavandula angustifolia
La lavanda a foglie strette è una specie con distribuzione mediterranea a baricentro occidentale, in Italia coltivata quasi ovunque ma presente allo stato spontaneo in poche regioni, prevalentemente lungo le coste tirreniche della Penisola. Cresce in macchie basse e garighe su substrati prevalentemente silicei. Viene coltivata sia a scopo ornamentale che per l'estrazione degli olii essenziali ampiamente usati in profumeria. Gli antichi Greci chiamavano questa pianta ‘nardo’, alludendo alla città siriana di Naarda: era una delle erbe sacre usate nel tempio di Gerusalemme (il nardo è menzionato più volte nella Bibbia, come ad es. nel Canto di Salomone). Conosciuta fin dai tempi più antichi per le proprietà antisettiche, analgesiche, battericide, vasodilatatorie, è considerata un blando sedativo. Il nome generico si riferisce all'antico uso per profumare i vestiti appena lavati, quello specifico alle foglie strette e sottili. Forma biologica: nanofanerofita. Periodo di fioritura: giugno-settembre.
-
 Crataegus monogyna
Crataegus monogyna
Il biancospino è un arbusto a distribuzione eurasiatico-sudeuropea presente in tutte le regioni d’Italia. È uno dei principali costituenti di boscaglie, macchie e siepi, e appare in tutti gli stadi dinamici della vegetazione legnosa, su suoli da carbonatici a debolmente acidi; colonizza persino le pietraie, sia pur con esemplari rattrappiti e deformi, dal livello del mare alla fascia montana inferiore, con optimum nella fascia submediterranea. Viene spesso utilizzato anche come pianta ornamentale per siepi e giardini, apprezzata per la fioritura prolungata e profumata e per il colore vivace dei frutti che perdurano a lungo. Le foglie e i frutti, commestibili ma insipidi, hanno proprietà officinali. Il legno di colore rossastro, duro e compatto, viene impiegato per lavori al tornio e per la produzione di carbonella. Il nome generico deriva dal greco 'kratos' (forza), antico nome comune della pianta, in riferimento alla durezza del legno; quello specifico deriva dal greco 'mónos' (unico) e 'gyné' (femmina), per l'ovario monocarpellare. Forma biologica: fanerofita cespugliosa. Periodo di fioritura: aprile-maggio.
-
 Myrtus communis
Myrtus communis
Il mirto, presente allo stato spontaneo nella macchia mediterranea, è spesso coltivato come pianta ornamentale in parchi e giardini, da cui a volte sfugge soprattutto nell'Italia mediterranea. Il nome generico deriva da ‘mýrtos’, quello greco della pianta, e questo forse deriva da ‘mýro’ (io stillo); è legato a quello di Myrsine, leggendaria fanciulla greca uccisa da un giovane da lei battuto nei giochi ginnici e trasformata da Pallade in un arbusto di mirto. Periodo di fioritura: giugno-luglio.
-
 Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
L'ippocastano è un albero ornamentale che può raggiungere i 30 metri, originario di un'area ristretta della Penisola Balcanica. Fu introdotto nel 1576 da Charles de L'Écluse (Clusius) nei giardini imperiali di Vienna e da qui, a distanza di tempo (sec. XVIII-XIX), venne distribuito attraverso i semi in tutto il territorio dell'impero austro-ungarico; per tale motivo risulta tradizionalmente impiegato soprattutto nell'Italia settentrionale. È coltivato in viali, parchi e giardini, a volte comparendo allo stato subspontaneo nei boschi termofili della fascia collinare. I semi, velenosi per effetto dei saponosidi che contengono, vengono talvolta consumati per errore perché scambiati per castagne o ritenuti commestibili come queste ultime. La pianta è usata a scopo farmaceutico (antiemorroidario), cosmetico e tintorio; i semi, schiacciati e pestati, erano impiegati per la produzione di sapone, specialmente in tempo di guerra. Le alberature sono oggi attaccate da un lepidottero (Cameraria ohridella) che causa il precoce appassimento delle foglie. Il nome generico era già in uso presso i romani (Virgilio), che però con esso designavano una quercia; il nome specifico deriva dal greco 'híppos' (cavallo) e 'kástanon' (castagna), per l'aspetto dei frutti a forma di grossi ricci a spine deboli e fragili contenenti grossi semi simili a castagne, utilizzati in Oriente come alimento per i cavalli. Forma biologica: fanerofita scaposa. Periodo di fioritura: aprile-maggio.
-
 Himantoglossum adriaticum
Himantoglossum adriaticum
Himantoglossum adriaticum
Il barbone adriatico è un’orchidea a distribuzione eurimediterraneo orientale (Italia e Penisola Balcanica) presente in tutte le regioni dell’Italia continentale salvo che in Valle d’Aosta e in Puglia. La distribuzione regionale si concentra nella parte sudorientale del territorio; in Carso la specie è localizzata sul M. Sabotino e nei dintorni di Trieste. Cresce negli orli di boschi termofili di latifoglie decidue e in prati submesofili, su suoli argillosi abbastanza profondi, ricchi in basi ma talvolta decalcificati, da neutri a subacidi, al di sotto della fascia montana inferiore. Il nome generico deriva dal greco 'himántos' (striscia di cuoio), e 'glossa' (lingua), per il lunghissimo labello nastriforme; il nome specifico si riferisce alla distribuzione centrata sulle regioni situate attorno al Mare Adriatico. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: maggio-luglio.
-
 Ravenala madagascariensis
Ravenala madagascariensis
Viene detta comunemente palma del viaggiatore, ma non è affatto una palma: è invece una specie erbacea ad alto fusto della famiglia delle Strelitziaceae. La maestosità di questa pianta è legata alla sua morfologia: all’apice del fusto, lungo circa una decina di metri, sono addensate le foglie simili a quelle del banano, disposte rigorosamente in un unico piano, a formare un enorme ventaglio. Il suo nome viene attribuito al fatto che alla base del picciolo, allargata a coppa, si raccoglie l'acqua piovana che scivola lungo il picciolo e che viene usata dai viaggiatori per dissetarsi. In realtà R. madagascariensis è endemica delle foreste pluviali del Madagascar, ambiente nel quale l’acqua abbonda, quindi è probabilmente più verosimile la versione che attribuisce il nome comune di questa pianta al fatto che il ventaglio di foglie è in tutti gli esemplari sempre orientato in una direzione precisa e funziona quindi come una bussola per il viaggiatore. In lingua malgascia il nome del genere significa “foglie della foresta”.
Specie simbolo del Madagascar, la silhouette inconfondibile della chioma di R. madagascariensis compare stilizzata nel logo della compagnia aerea nazionale.
Fra le guaine delle ultime foglie compaiono le infiorescenze, costituite da spighe di numerosi fiori bianchi, protette da grandi brattee distiche. L’impollinazione è ad opera di pipistrelli e lemuri.
I frutti sono capsule in cui i semi sono avvolti in fibre di colore blu intenso che attirano gli uccelli che disseminano la specie.
Le foglie sono utilizzate come materiale per la costruzione delle tradizionali abitazioni, mentre dal fusto si ricava una grasso commestibile
-
 Hottonia palustris
Hottonia palustris
Hottonia palustris
Il fertro è una specie a vasta distribuzione eurosiberiana presente, ma piuttosto rara, in tutte le regioni dell'Italia settentrionale (salvo che in Valle d’Aosta e Liguria), in Toscana e in Lazio. La distribuzione regionale si concentra nella bassa pianura friulana al di sotto della linea delle risorgive, con stazioni anche nell'area dell'anfiteatro morenico e nelle aree umide del Carso goriziano. Cresce in acque stagnanti poco profonde, mesotrofiche, povere di sostanze disciolte e di calcare, spesso in stazioni ombrose e su fango torboso, dal livello del mare a circa 800 m. Il genere è dedicato al medico e botanico olandese Petrus Hotton (1648-1709); il nome specifico si riferisce all’habitat. Forma biologica: idrofita radicante. Periodo di fioritura: aprile-maggio.