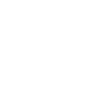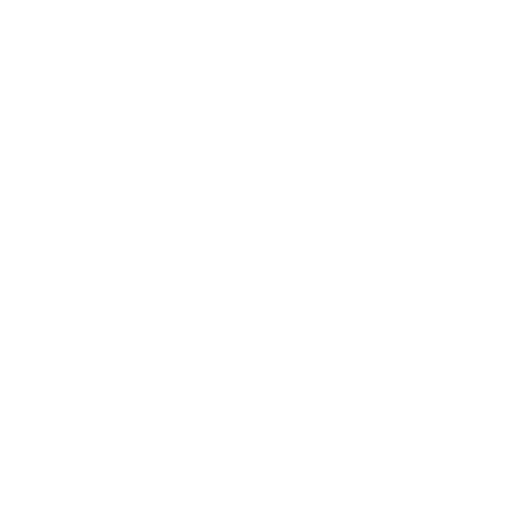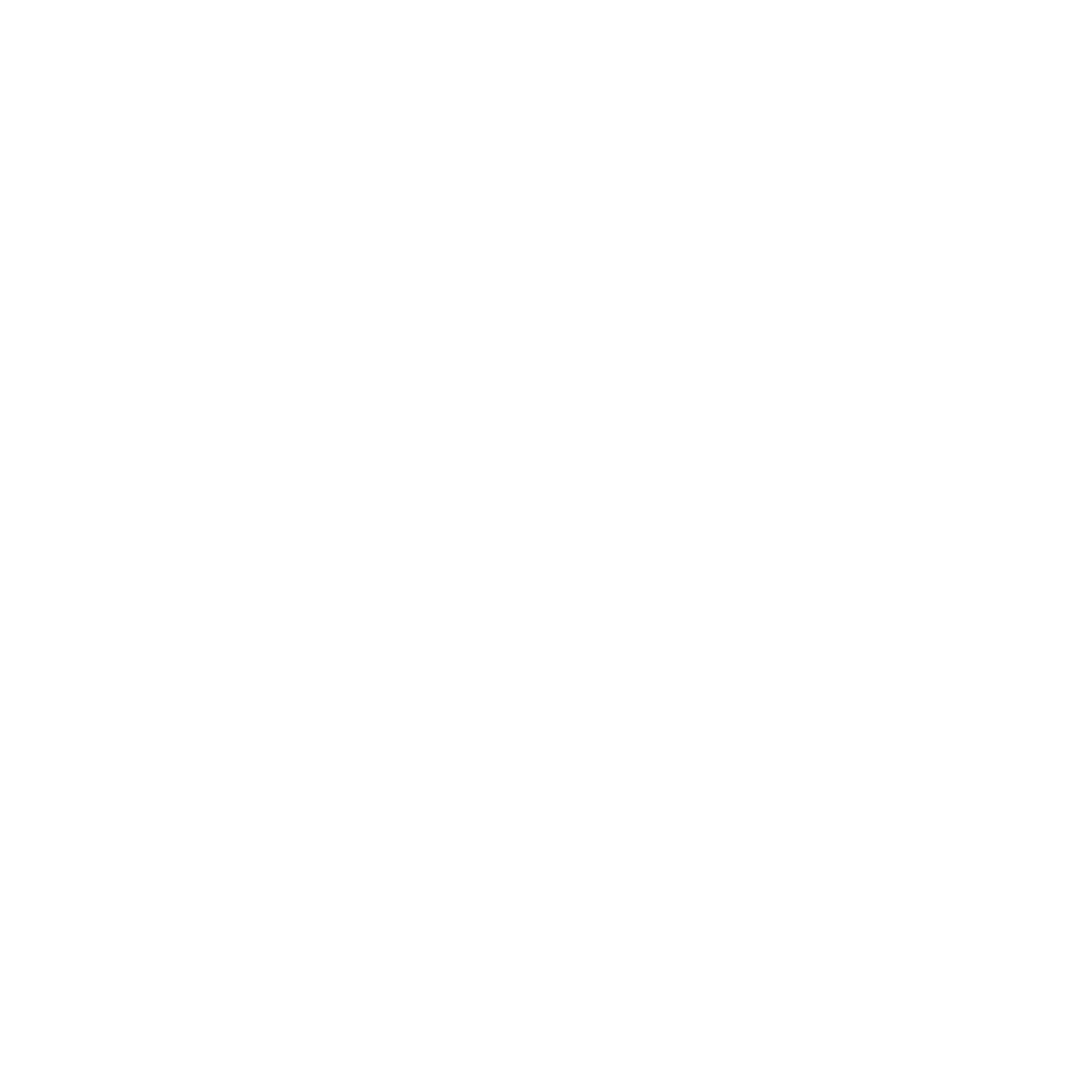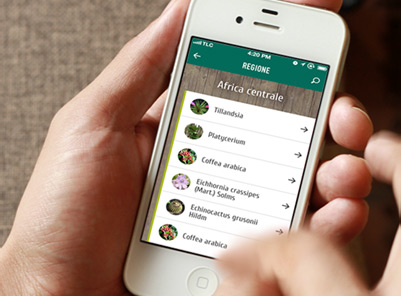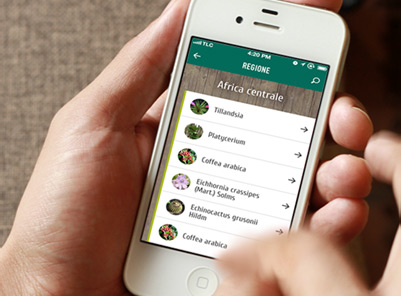You can visit the Old Garden, the 19th-century greenhouses, the arboretum, and the Botanical Museum
Find out more
An integrated ticket to visit the Botanical Garden, Palazzo del Bo and the new Museum of Nature and Humankind
Find out more
The new restoration project involve the central fountain, the fountains of the quarters, of Theophrastus and of the Four Seasons
Find out moreSpecie botaniche
-
 Aesculus hippocastanum
Aesculus hippocastanum
L'ippocastano è un albero ornamentale che può raggiungere i 30 metri, originario di un'area ristretta della Penisola Balcanica. Fu introdotto nel 1576 da Charles de L'Écluse (Clusius) nei giardini imperiali di Vienna e da qui, a distanza di tempo (sec. XVIII-XIX), venne distribuito attraverso i semi in tutto il territorio dell'impero austro-ungarico; per tale motivo risulta tradizionalmente impiegato soprattutto nell'Italia settentrionale. È coltivato in viali, parchi e giardini, a volte comparendo allo stato subspontaneo nei boschi termofili della fascia collinare. I semi, velenosi per effetto dei saponosidi che contengono, vengono talvolta consumati per errore perché scambiati per castagne o ritenuti commestibili come queste ultime. La pianta è usata a scopo farmaceutico (antiemorroidario), cosmetico e tintorio; i semi, schiacciati e pestati, erano impiegati per la produzione di sapone, specialmente in tempo di guerra. Le alberature sono oggi attaccate da un lepidottero (Cameraria ohridella) che causa il precoce appassimento delle foglie. Il nome generico era già in uso presso i romani (Virgilio), che però con esso designavano una quercia; il nome specifico deriva dal greco 'híppos' (cavallo) e 'kástanon' (castagna), per l'aspetto dei frutti a forma di grossi ricci a spine deboli e fragili contenenti grossi semi simili a castagne, utilizzati in Oriente come alimento per i cavalli. Forma biologica: fanerofita scaposa. Periodo di fioritura: aprile-maggio.
-
 Chamaerops humilis
Chamaerops humilis
La palma nana è l’unica palma spontanea in Italia. In natura cresce nella macchia mediterranea, e da noi è diffusa soprattutto lungo le coste tirreniche, mentre altrove viene spesso coltivata a scopo ornamentale. Gli esemplari dell’Orto botanico di Padova, che raggiungono dimensioni ragguardevoli, sembra siano stati piantati nel 1585 e vengono chiamati anche ‘palma di Goethe’ , in quanto furono citati dal grande scrittore tedesco nella sua importante opera dedicata alla metamorfosi delle piante. Il nome generico deriva dal greco 'khamai' (piccolo) e 'rhops' (arbusto, cespuglio), alludendo alle piccole dimensioni della pianta negli ambienti naturali; il nome specifico ha lo stesso significato. Forma biologica: fanerofita scaposa/ nanofanerofita. Periodo di fioritura: maggio-giugno.
-
 Humulus lupulus
Humulus lupulus
Il luppolo è una specie a distribuzione eurasiatico-nordamericana presente in tutte le regioni d’Italia. Originario di boschi alluvionali periodicamente inondati, si è trasferito in siti ruderali su suoli limoso-argillosi freschi e piuttosto profondi, ricchi in composti azotati, dal livello del mare a 1.200 metri circa. I fiori, sia femminili che maschili, sono utilizzati nel processo della produzione della birra, a cui il luppolo conferisce il tipico aroma. I getti giovani vengono utilizzati come gli asparagi per condire risotti e frittate. Il nome generico deriva da quello altogermanico della pianta (Humel), utilizzata per la produzione della birra; quello specifico è di significato incerto. Forma biologica: fanerofita lianosa. Periodo di fioritura: maggio-agosto.
-
 Capparis spinosa
Capparis spinosa
Il cappero è un arbusto prevalentemente mediterraneo, presente allo stato spontaneo in quasi tutte le regioni d'Italia ma più comune al centro-sud. Cresce su rupi e vecchi muri, in luoghi assolati e caldi. Già descritto da Dioscoride e Galeno che gli attribuivano proprietà medicinali, è ancor oggi ampiamente utilizzato in cucina ove si utilizzano i fiori immaturi trattati in salamoia o sotto sale (capperi); in alcune regioni vengono mangiati e commercializzati anche i frutti (cucunci). Il nome generico sembra derivare da quello arabo della pianta ('kabar' o ' kappar'), il nome specifico si riferisce alle stipole che a volte si trasformano in spine. Forma biologica: nanofanerofita. Periodo di fioritura: maggio-giugno.
-
 Coriandrum sativum
Coriandrum sativum
Il coriandolo è una pianta annua originaria dalla parte sud-occidentale della regione mediterranea, oggi ampiamente coltivata in tutto il mondo; in Italia è presente in quasi tutte le regioni come specie avventizia sfuggita alla coltura. Cresce in ambienti disturbati e soprattutto nelle colture di frumento, dal livello del mare ai 1.000 metri circa. Nelle civiltà mediterranee trovò impiego come pianta aromatica e medicinale sin dal tempo degli egizi e dei micenei. Dai semi rivestiti di zucchero prendono nome i coriandoli di Carnevale, ora dischetti di carta multicolori. Benché originario dei paesi del Mar Mediterraneo, le foglie fresche e i frutti sono utilizzati prevalentemente nelle cucine indiana e latino-americana. Il nome generico deriva dal greco ‘korios’ (cimice) in riferimento alla somiglianza dell'odore della pianta con quello delle cimici dei letti; il nome specifico significa ‘coltivato’. Forma biologica: terofita scaposa. Periodo di fioritura: maggio-giugno.
-
 Bauhinia aculeata
Bauhinia aculeata
Per la bellezza del suo fiore questa specie viene anche chiamata dagli anglosassoni “albero delle orchidee bianche”. Il genere fu dedicato ai fratelli Bauhin, illustri botanici svizzeri. Arbusto dai lunghi rami flessibili che si appoggiano alle piante circostanti. Le foglie sono bilobate, molto caratteristiche. I grandi fiori bianchi presentano cinque lunghi petali e numerosi stami bianchi dai filamenti allungati e spesso curvi, come pure lungo e curvo è il pistillo centrale
-
 Digitalis lutea
Digitalis lutea
La digitale gialla meridionale è un’entità endemica della penisola italiana, dall'Emilia alla Calabria. Cresce in radure di faggete e boschi misti, nei pascoli e nei cespuglieti, con optimum nella fascia montana inferiore. Tutte le specie di Digitalis contengono un gruppo di glucosidi con potente effetto cardiotonico che le rendono fortemente velenose; oggi queste vengono sintetizzate in laboratorio ed ampiamente usate nell'industria farmaceutica. Il nome generico deriva dal latino 'digitalis' (del dito, ditale) per la forma della corolla; il nome specifico in latino significa ‘gialla’; il nome della sottospecie significa 'meridionale'. Forma biologica: emicriptofita scaposa. Periodo di fioritura: maggio-luglio.
-
Delphinium fissum
Delphinium fissum
La speronella lacerata è una specie delle montagne dell'Eurasia presente in tutte le regioni dell’Italia continentale salvo che in Liguria, Valle d’Aosta, Lombardia e Trentino-Alto Adige. Cresce in prati aridi e boschi cedui molto aperti, su substrati calcarei, con optimum nella fascia montana inferiore. Tutte le parti della pianta sono tossiche se ingerite per la presenza di alcaloidi. Il nome generico deriva dal greco ‘delphís’ (delfino), per la forma del fiore vagamente simile a quella di un delfino; il nome specifico in latino significa ‘profondamente diviso’ in riferimento alla forma delle foglie. Forma biologica: emicriptofita scaposa. Periodo di fioritura: giugno-agosto.
-
 Himantoglossum adriaticum
Himantoglossum adriaticum
Himantoglossum adriaticum
Il barbone adriatico è un’orchidea a distribuzione eurimediterraneo orientale (Italia e Penisola Balcanica) presente in tutte le regioni dell’Italia continentale salvo che in Valle d’Aosta e in Puglia. La distribuzione regionale si concentra nella parte sudorientale del territorio; in Carso la specie è localizzata sul M. Sabotino e nei dintorni di Trieste. Cresce negli orli di boschi termofili di latifoglie decidue e in prati submesofili, su suoli argillosi abbastanza profondi, ricchi in basi ma talvolta decalcificati, da neutri a subacidi, al di sotto della fascia montana inferiore. Il nome generico deriva dal greco 'himántos' (striscia di cuoio), e 'glossa' (lingua), per il lunghissimo labello nastriforme; il nome specifico si riferisce alla distribuzione centrata sulle regioni situate attorno al Mare Adriatico. Forma biologica: geofita bulbosa. Periodo di fioritura: maggio-luglio.
-
Epipactis thesaurensis
Specie osservabile solo in natura: la pianta presente all’Orto botanico (Epipactis palustris) appartiene allo stesso genere.
Il nome della specie deriva dal Monte Tesoro, nel territorio del comune di S. Anna d’Alfaedo, nel settore occidentale dei Monti Lessini. E’ nota unicamente per la Lessinia veronese, con due stazioni nella parte occidentale e una nella parte orientale, scoperta nel 2009. Predilige i boschi di latifoglie, su suolo poco acido, da 650 a 900 m di quota. Alta fino a 40 cm, lungo il fusto presenta foglie molto lunghe, infiorescenza con fiori penduli e poco aperti, con sepali verdi e petali di verdognoli con sfumature rosate, caratterizzati dalla parte apicale del labello, chiamata epichilo, di color violetto. Fiorisce nella stagione estiva, in luglio.
E’ stata descritta recentemente, nel 2007, e la sua distribuzione è ancora in fase di studio, come pure ancora dibattuta è la sua posizione tassonomica.
Nella Lista Rossa del Veneto è classificata come “NT”, quasi a rischio di estinzione.
-
 Erythrina crista-galli
Erythrina crista-galli
L’eritrina, o ceibo, è un albero originario di Argentina, Uruguay, Brasile meridionale e Paraguay. La pianta è l’albero nazionale dell’Argentina, e il fiore viene considerato il fiore nazionale dell’Argentina e dell’Uruguay. Venne introdotta in Inghilterra nel 1771 e giunse in Italia pochi anni dopo, come testimonia l'ultracentenario esemplare nel giardino di Villa Pamphili a Roma, di fronte al Casino dell'Algardi. Nelle parti più calde dell’Europa meridionale viene a volte utilizzata come pianta ornamentale per le vistosissime fioriture di colore rosso, anche se la coltivazione non è molto facile in quanto la pianta soffre i periodi di aridità estiva tipici del clima mediterraneo; nell’area di origine la specie cresce infatti nelle foreste a galleria lungo il basso corso dei fiumi, oppure in acquitrini e paludi. Nell’area di origine viene impollinata da uccelli per attirare i quali produce tanto nettare che spesso gocciola dai fiori, da cui il nome inglese ‘cry-baby’. Il nome generico, dal greco ‘erhytros’ (rosso) si riferisce al colore dei fiori, quello specifico, che in latino significa ‘cresta di gallo’, alla forma della corolla. Periodo di fioritura: maggio-settembre
-
 Daphne mezereum
Daphne mezereum
Il fior di stecco è un piccolo arbusto a distribuzione eurasiatico-continentale presente in tutte le regioni dell’Italia continentale salvo che in Puglia. Cresce nei boschi mesofili di latifoglie decidue e nelle loro radure, dai querco-carpineti alle faggete, su suoli argillosi piuttosto profondi, dalla fascia submediterranea alla fascia montana superiore. Tutte le parti della pianta sono estremamente velenose per la presenza di un glucoside (dafnina). Le dafne sono note fin dall'antichità per le proprietà farmacologiche, ma il loro uso è molto pericoloso e spesso il solo contatto con l'epidermide causa arrossamenti e vesciche sulla pelle. I frutti rossi, la cui ingestione provoca avvelenamenti anche mortali, sono stati impiegati in pittura e anche come fard in Siberia, cosmetico non meno pericoloso della biacca usata dalle matrone romane. Il nome generico deriva da 'dàphne', nome greco dell'alloro, per le foglie sempreverdi di alcune specie come D. laureola; il nome specifico deriva dall'arabo e significa 'mortale'. Forma biologica: nanofanerofita. Periodo di fioritura: marzo-maggio.